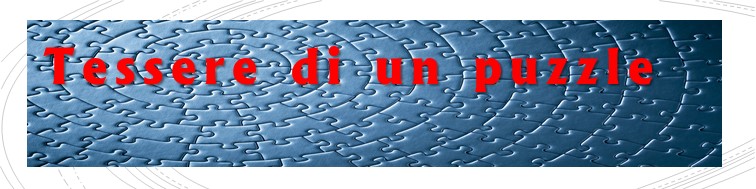A ottobre del 1922, a New York andò in scena RUR, la commedia che avrebbe cambiato il mondo con una sola parola. Scritta dal commediografo ceco Karel Čapek, era stata rappresentata diciotto mesi prima in Cecoslovacchia. Ancor prima di debuttare a Londra, nel 1923, la commedia era stata tradotta in trenta lingue. L’influenza planetaria del titolo dipendeva dal fatto che il titolo era l’acronimo di Rossum’s Universal Robots (I robot universali di Rossum), da cui sarebbe scaturito il termine ora universale «robot». Čapek l’aveva adattato da una vecchia parola ceca, che significava «schiavitú». Nella commedia, la società si basa sul lavoro di docili robot creati dallo scienziato Rossum; quando i robot acquisiscono un elemento di natura umana, uccidono i loro padroni. Pur composti di una qualche strana carne meccanizzata (tecnicamente sono quindi dei cyborg), i robot non possono riprodursi. Tuttavia, nell’atto finale due robot sconfiggono la propria sterilità. Saranno i nuovi Adamo ed Eva.
Cobb, Matthew. Mente e cervello: Una storia filosofica e scientifica (Italian Edition) (p.200). EINAUDI. Edizione del Kindle.
Rivoluzioni nei Paesi Bassi e in Inghilterra ribaltarono i vecchi poteri aristocratici, favorendo un nuovo spazio politico, sociale ed economico per nuove classi, che avevano concezioni del mondo piú radicali. Intanto, la scoperta delle Americhe da parte degli Europei e la comparsa di nuove malattie, come la sifilide, minarono la fede nei testi antichi, che si rivelarono di scarsa utilità per comprendere questi sviluppi inediti. Infine, l’invenzione del telescopio e del microscopio rivelarono mondi fino ad allora inimmaginabili, mentre sviluppi tecnologici come la pompa a pistoni e l’orologio meccanico fornirono nuove suggestive metafore che parevano spiegare come potesse funzionare ogni cosa, dal moto degli astri al corpo umano.
Cobb, Matthew. Mente e cervello: Una storia filosofica e scientifica (Italian Edition) (pp.41-42). EINAUDI. Edizione del Kindle.
È questa l'innegabile grandezza del diritto: esso ci costringe tutti a fecalizzare la nostra attenzione sull'individuo, sulla persona, anche nell'epoca della società di massa, un'epoca in cui tutti si considerano più o meno come ingranaggi dì una grande macchina - sia questa la macchina ben oliata di qualche gigantesco apparato burocratico, sociale, politico o professionale, o la macchina caotica e rattoppata delle semplici circostanze fortuite in cui sono intrappolate le nostre vite. Lo scaricabarìle delle responsabilità, uno scaricabarile pressoché automatico nelle società moderne, trova sempre un punto d'arresto sulla soglia del tribunale. Ogni giustificazione dì carattere troppo astratto - dallo Zeitgeist al complesso d'Edipo, concetti che fanno di noi tutti, non tanto degli uomini, quanto delle rotelle di qualcosa di più grande - ogni giustificazione di questo tipo vien meno. Non importa quali siano le mode scientifiche del tempo, non importa quanto esse abbiano pervaso e persuaso l'opinione pubblica, influenzando anche i professionisti del diritto: l'istituzione giuridica deve sfidare tutto questo, se vuole continuare a esistere, E non appena ci si para dinanzi un individuo, la domanda non può più essere: «Come funziona il sistema?», ma: «Perché l'imputato è diventato un funzionario di questa o quest'altra organizzazione?»
ARENDT H. Alcune questioni di filosofia morale. Einaudi, 2006. p 12
Gli effetti della divisione gerarchica e funzionale del lavoro
L'uso della violenza massimizza l'efficienza e riduce al minimo i costi quando i mezzi impiegati sono soggetti esclusivamente ai criteri della ragione strumentale, e perciò dissociati dalla valutazione morale dei fini. Come si è fatto notare nel primo capitolo, questa dissociazione è un'operazione in cui tutte le burocrazie sono maestre. Si potrebbe persine dire che essa costituisce l'essenza della struttura e del processo burocratico, e con ciò il segreto di quella tremenda crescita della capacità di mobilitazione e coordinazione, e della razionalità ed efficienza dell'azione, che la civiltà moderna ha raggiunto grazie allo sviluppo dell'amministrazione burocratica. Tale dissociazione è in buona misura il risultato di due processi paralleli, entrambi essenziali per il modello burocratico di azione. Il primo processo è dato dalla minuziosa divisione funzionale del lavoro (come fenomeno aggiuntivo e distinto nelle sue conseguenze rispetto alla distribuzione lineare del potere e della subordinazione); il secondo processo è dato dalla sostituzione della responsabilità tecnica a quella morale.
La divisione del lavoro (anche quella che deriva dalla semplice gerarchia dell'autorità) crea sempre una distanza tra la maggior parte di coloro che contribuiscono al risultato finale dell'attività collettiva e il risultato stesso. Prima che gli ultimi anelli della catena burocratica del potere (gli esecutori diretti) affrontino il proprio compito, le operazioni preparatorie di quella fase sono già state in gran parte svolte da persone prive di qualsiasi esperienza personale, e in alcuni casi di qualsiasi conoscenza, del compito in questione. A differenza di quanto avviene in una unità di lavoro premoderna, in cui tutti i gradini della gerarchia hanno in comune le stesse capacità professionali, e la conoscenza pratica delle operazioni lavorative cresce via via che si sale lungo la scala (il maestro di bottega sa le stesse cose che sanno i suoi lavoranti e apprendisti, ma le conosce di più e meglio), le persone che occupano livelli successivi della burocrazia moderna differiscono radicalmente per il tipo di competenza e di formazione professionale che il loro lavoro richiede.
BAUMAN Z. (1992). Modernità e olocausto. Il Mulino. p 143
Dati i limiti della conoscenza e delle capacità di calcolo, spesso le persone non sono in grado di giudicare se particolari convinzioni siano vere e se determinati comportamenti contribuiscano alla loro utilità (ricchezza, potere o qualsiasi forma essa assuma).
L'ipotesi di razionalità limitata è cruciale per la spiegazione del comportamento umano non soltanto nel contesto della docilità, ma potenzialmente in tutte le situazioni della vita reale, poiché gli esseri umani non sono mai, neanche remotamente, nella posizione di conoscere tutte le azioni alternative o di valutare le conseguenze di ogni azione. I limiti della conoscenza e del calcolo occupano una posizione centrale nella condizione umana.
SIMON HA. (2000). Scienza economica e comportamento umano. Edizioni di Comunità. pp 42-44